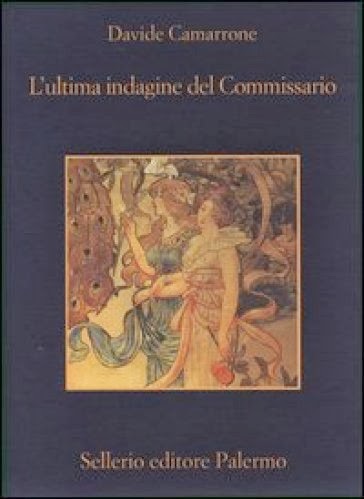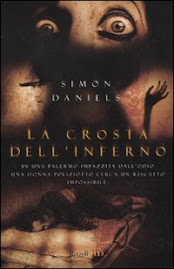venerdì 5 ottobre 2012
IO STO CON INGROIA
Ricevo questa telefonata. È giovedì pomeriggio. Ma Ingroia, mi chiedono. Ha firmato degli autografi e qualcuno protesta. Tu che ne pensi? Sto dalla sua parte, rispondo. Dalla parte di Antonio Ingroia e di quelli che gli chiedono un autografo. Io mi ricordo. Erano gli anni Ottanta. Avevano già ucciso. Mattarella. La Torre. E tanti altri, buoni e meno. Nell’83, ricorsero al tritolo, per l’autobomba che uccise Rocco Chinnici. Un’azione di guerra. Libanese, dissero. E libanesi furono altre stragi. Fino a quelle del ’92 e del ’93. Mi ricordo quei magistrati che a Palermo, con Chinnici, provarono a scardinare un intero sistema, colpendo anzitutto Cosa Nostra.
Oggi abbiamo la consapevolezza che il sistema criminale italiano si fonda da una parte sulla prevaricazione legalitaria – leggi ad hoc, professionisti dello svuotamento del senso residuo delle leggi, imprenditori – e dall’altra sulla violenza, delle mafie e di altri soggetti armati. Di quei magistrati che provavano a incrinarne il funzionamento, uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dicevano, fra l’altro: comunisti, golpisti, illusi, narcisisti, pazzi. Tralascio gli insulti. Sono passati vent’anni. Falcone e Borsellino non riuscirono a demolire quel sistema criminale. E furono uccisi, dalla mafia e dai suoi alleati, per obiettivi non solo mafiosi: a dircelo, oggi, sono storici e magistrati. La Trattativa che si svolse tra Stato e Mafia è stata raccontata da pentiti e testimoni.
C’è anche il colossale depistaggio sulla strage di via D’Amelio. Manca la verità sui delitti politici. E vengono fuori verità un tempo indicibili sui rapporti tra mafia, neofascismo e poteri occulti: dalla revisione del processo per la strage di Alcamo, ad esempio. Tutto si tiene. In più, rispetto ad allora, c’è l’inveramento della profezia di Sciascia sui professionisti dell’antimafia. Si ha l’impressione che sotto la maschera di antimafiosi oggi possano nascondersi dei rappresentanti di interessi, come dire, sgradevoli. Antonio Ingroia ha il coraggio di denunciare il fallimento di quel tentativo di scardinamento, proseguito fino ad oggi con coraggio e nonostante i tanti morti. Fallimento che, a mio parere, non è solo della magistratura onesta. È nostro, di tutti noi. Ingroia dice con tono pacato e con argomenti seri di quel che è accaduto e accade. Ha svolto una funzione di supplenza. Parlo al passato prossimo perché sta per andar via da Palermo, sia pure per un anno, per un incarico ONU. In Guatemala, e non alle Bahamas. Ingroia non va via da vincitore. Ma da sconfitto. Lui come tanti italiani.
Confesso che per qualche tempo ho criticato i magistrati che rilasciavano interviste sui processi dei quali si erano occupati. Distinguevo tra Gherardo Colombo e Antonio Di Pietro, tanto per dire. Avevo voglia di normalità. Ora mi sento trascinato indietro nel tempo. Ad anni terribili. Ripenso alla ragione della telefonata. Ingroia ha firmato degli autografi. E mi dico, quasi quasi, gliene chiedo uno anch’io.
domenica 15 luglio 2012
CHE SUCCEDE NELLA CHIESA SICILIANA?
C’era un tempo, non lontano, a Palermo, in cui un arcivescovo s’ingeriva di frequente nelle cose della politica: c’era “una grave congiura – scrisse, in una lettera pastorale, nel 1964 - per disonorare la Sicilia”, e colpevoli ne erano la mafia, il Gattopardo e Danilo Dolci.
A Monreale, negli anni Ottanta, un altro arcivescovo, grand'Ufficiale dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, fu implicato in alcune inchieste di mafia e poi prosciolto, condannato in appello per una truffa all’Unione Europea e poi definitivamente assolto, dopo un annullamento della Corte di Cassazione.
Nel 1982, a Palermo, celebrando i funerali del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il cardinale Salvatore Pappalardo tuonò contro Cosa nostra e chiese alla politica di salvare Sagunto: Palermo, oramai espugnata.
Fu una svolta.
Molti parroci scelsero di parlarne con i fedeli, pronunciando una parola a lungo bandita dalle omelie: Mafia!
La Primavera di Palermo nacque nelle stanze di un centro studi dei Gesuiti, con padre Ennio Pintacuda e padre Bartolomeo Sorge.
Nel 1993, ad Agrigento, il Papa, Giovanni Paolo II, si rivolse ai mafiosi, ordinando loro: “Convertitevi”.
Pochi mesi dopo, a Palermo, giunse la risposta di Cosa Nostra: il parroco di Brancaccio, Don Pino Puglisi, presto Beato, fu ucciso a colpi di pistola; aveva provato a sottrarre i ragazzi all’abbraccio mortale dei boss, solo esempio d’ascesa sociale, nelle periferie.
Ombre e luci, dunque.
Al punto che, nel 1996, un teologo siciliano, padre Francesco Michele Stabile, scrisse: “Perché la Chiesa in Sicilia non ha individuato la mafia non solo come nemico della vita civile, ma soprattutto come un impedimento alla evangelizzazione e alla coerenza di vita della comunità cristiana?”.
Nell’ultimo anno, nella Chiesa siciliana sono accadute molte cose. Alcune tra le più rilevanti conducono a Trapani, dove il vescovo è stato rimosso per le conclusioni di un’inchiesta interna disposta dal Vaticano (e condotta dal vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero), e un arciprete è indagato dalla Procura locale per la gestione degli immobili della Curia; o ad Acireale, dove un sacerdote ha conversato, non sapendo d’esser registrato, dei suoi rapporti con un uomo al tempo in cui quest’ultimo era minorenne: il sacerdote è stato sospeso dalle sue funzioni e i pm hanno aperto un’indagine.
Penso a tutto questo - alla Chiesa e alla Sicilia di ieri e di oggi -, mentre leggo delle cronache romane.
Lo Ior di nuovo al centro delle cronache (e nell’inchiesta capitolina confluiscono pure i fatti di Trapani). La defenestrazione del Presidente della Banca Vaticana, Ettore Gotti Tedeschi, collaboratore del Papa nella stesura dell’enciclica “Caritas in Veritate”. Poi, l’arresto del maggiordomo del Santo Padre, che avrebbe trafugato delle lettere riservate e pubblicate in un libro inchiesta. E infine, le rivelazioni sui rapporti tesissimi nella Chiesa tra due ali: quella innovatrice, che fa capo all’attuale Pontefice, e quella conservatrice, legata ai vecchi assetti.
Il Papa, Joseph Ratzinger, ex capo della Congregazione per la Dottrina della Fede (l’ex Sant’Uffizio), è un intellettuale: docente a Tubinga negli anni del Concilio, e vicinissimo, in quel tempo, al teologo progressivo Hans Kung. Non certo un uomo di potere.
Giunto al sacro soglio, Papa Benedetto XVI aveva lanciato segnali chiari, sin dalla nomina di Padre Federico Lombardi a suo portavoce, seminando autentico entusiasmo nella Chiesa: un enfant prodige, padre Lombardi, giovanissimo provinciale d’Italia dei Gesuiti al tempo della Primavera di Palermo, nominato a soli 42 anni.
Benedetto XVI si è proposto di restituire trasparenza alle finanze vaticane e di ridimensionare alcuni poteri cresciuti a dismisura negli ultimi trent’anni. E ha infranto il tabù della pedofilia. Nella lettera ai cattolici irlandesi del 19 marzo 2010, parlando dei sacerdoti colpevoli di abusi sessuali, ha scritto: “Avete tradito la fiducia riposta in voi da giovani innocenti e dai loro genitori. Dovete rispondere di ciò davanti a Dio onnipotente, come pure davanti a tribunali debitamente costituiti”.
Penso che, come me, tanti siano smarriti, disorientati. Chi tiene alla Chiesa, deve sostenere questo Pontefice coraggioso, capace di autentici gesti di rottura: anche in Sicilia. Forse non riuscirà nell’impresa. Ma se fallirà, sarà anche per il nostro silenzio.
sabato 30 giugno 2012
CONVERSAZIONE CON DI LELLO SULLA TRATTATIVA
Ci sono parole che, con il tempo, perdono di senso, di significato. Dietrologia è una di queste.
Il nostro contesto interpretativo è l’Italia (e già “contesto” è un termine letterario, per via del romanzo di Leonardo Sciascia: ambiguo per eccellenza, multiforme, e dunque adatto all’investigazione).
Anni fa, in Italia, dietrologi erano coloro che intravedevano, dietro i fatti di sangue e i rivolgimenti politici, delle trame tessute da certi poteri che agivano nell’ombra: servizi segreti italiani e stranieri, poteri economici e politici, lobbies e confraternite.
Ora, dinanzi all’esito di indagini giudiziarie e inchieste giornalistiche sulle stragi del ’92, bisogna chiedersi: che significa dietrologia? Furono dietrologi coloro che si esercitarono nel sospetto, coloro che rimasero insoddisfatti delle indagini e delle verità di Stato?
Vi fu una trattativa, dicono pm e testimoni, che coinvolse uomini della mafia e dello Stato: mentre Cosa Nostra preparava il tritolo per Capaci e Via d’Amelio.
Paolo Borsellino sapeva che sarebbe stato ucciso. Era stato avvertito. Si era preparato alla morte.
Si dice che uomini dello Stato fossero “punciuti”: che fossero passati per l’iniziazione mafiosa, che prevede una puntura di spillo, su un dito, e la fuoriscita del sangue, da cospargere su un’immagine sacra, che brucerà come le carni dell’iniziato, se tradirà.
Si dice che uomini delle istituzioni abbiano depistato, sin dall’inizio, le indagini sulle stragi.
Si dice che Falcone e Borsellino siano stati accompagnati dinanzi al plotone d’esecuzione.
Bisogna chiedere ai testimoni, ai sopravvissuti: che è successo?
Giuseppe Di Lello è stato giudice istruttore al tempo di Rocco Chinnici: testimone, dunque.
È rimasto nel pool antimafia pure al tempo di Antonino Caponnetto, con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Poi, dal 1999, è stato deputato europeo e senatore, per Rifondazione Comunista. Ora è in pensione.
Giuseppe Di Lello ha assistito, ha preso parte; ha visto e pianto. È un esile e roccioso abruzzese di Villa Santa Maria, nel Teatino; arrivato in Sicilia dopo il concorso, nel 1971, e rimasto in Sicilia, per amore e per passione civile. Me lo ricordo, in una fotografia in bianco e nero: ad una camera ardente. Dinanzi ad una bara. In toga. Il volto più magro del solito. Un’espressione sofferente, dietro gli occhiali spessi. Forse per la morte di Chinnici, o di Falcone, di Borsellino.
Ma è possibile? Una trattativa tra mafia e Stato?
Devo fare una premessa. Sono sempre stato restio ad inseguire un complotto mondiale. Contrario ad immaginare una storia d’Italia ispirata al meccanismo servizi-mafia-complotti. La storia d’Italia è stata costruita anche da tante forze democratiche e sindacati che la mafia hanno sempre combattuto. Però bisogna dire che il depistaggio del processo Borsellino è emblematico. Non è detto che sia stato tutto dovuto al solo Questore di Palermo Arnaldo La Barbera. È solo un esempio, naturalmente. Dietro la strage di via D’Amelio, ci doveva esser dietro qualcuno che non fosse solo mafia. La Barbera era un personaggio abbastanza equivoco. Era a libro paga dei servizi. Vista retrospettivamente, questa vicenda dell’agenda e dell’invenzione di Scarantino comincia a spiegare che dietro questi fatti non poteva esserci solo mafia. Dando ragione a Falcone, che a proposito del fallito attentato contro di lui e due giudici svizzeri all’Addaura parlò di “menti raffinatissime”. Falcone aveva capito tutto. Anche che Salvo Lima non era un mafioso, nel senso che non era “punciuto”. Falcone lo disse anche a Ciriaco De Mita, che allora era segretario della DC. Lima era un punto di raccordo tra la mafia e la politica. Ma non aveva il calibro del mafioso. E lo sapevano anche i mafiosi. Forse, era anche un po’ millantatore, avendo offerto una specie di assicurazione sull’aggiustamento dei processi. E prendeva i voti dei mafiosi.
Forse l’assassinio di Lima fu un colpo tirato a freddo contro Giulio Andreotti: non doveva essere eletto Presidente della Repubblica. E Capaci, potrebbe esser stato il colpo di grazia.
Fu a mio parere un fatto accessorio, un danno collaterale. L’attentato di Capaci era stato preparato con anticipo. Così come quello di via D’Amelio, nonostante l’accelerazione decisa dopo la morte di Falcone.
E gli Stati Uniti? Non avevano mai visto in Andreotti un interlocutore credibile. Troppo filo arabo, e in un momento molto difficile.
Penso che gli Usa avessero l’obiettivo di combattere la mafia. Tennero in custodia per noi Buscetta e Marino Mannoia, facendoci un gran favore. E Buscetta parlò dei Salvo e di Andreotti.
Gli Usa però non cedettero mai un altro loro detenuto: Gaetano Badalamenti. E Badalamenti, contrariamente a Buscetta, era stato un capo: il capo di Cosa Nostra in Italia. E se avesse parlato Badalamenti?
Avrebbe fatto luce sui reali rapporti tra mafia e politica. Buscetta parlò solo, e bene, di mafia militare. Ma tenne per sé molti segreti. E tacque di sé. Non era stato un capo, ma forse, immagino, aveva ucciso, con le sue mani. Si pensa che lo abbia fatto. Era uno degli affiliati ad un clan sanguinoso, quello dei La Barbera. Ma di questo, con noi, non parlò mai.
Più volte ho pensato a Cosa Nostra come ad un’agenzia criminale, sul mercato, e non come ad un’entità criminale a se stante.
Le due cose non sono in contraddizione. Credo che la mafia abbia agito anche su impulsi esterni ma badando sempre ai suoi interessi.
Parliamo di omicidi politici. Nel ’78, le BR e chissà chi altri uccidono Aldo Moro. Nel ’79, la mafia – e chissà chi altri – uccide Michele Reina. Nell’80, tocca a Piersanti Mattarella. Tutti e tre, democristiani. Tutti e tre, protagonisti di aperture al PCI: a Roma, a Palermo, alla Regione. Tutti e tre, morti. Con loro, finisce la politica di solidarietà nazionale.
Non c’è dubbio che se devi uccidere qualcuno di importante in Sicilia non puoi non passare per quest’organizzazione criminale. E dunque è possibile che se altri volessero la morte di Reina e Mattarella, siano passati per la mafia.
Si è sempre detto, però, che per Reina e Mattarella vi era un movente mafioso: non un semplice uso strumentale della mafia da parte di terzi. E i depistaggi cominciano subito. Per Reina, s’assistette ad una messinscena con finte rivendicazioni terroristiche, da parte di BR e Prima Linea: e le indagini s’incagliarono. Per Mattarella, fu cassata la testimonianza della vedova, testimone oculare dell’assassinio, che aveva riconosciuto nel terrorista nero Giusva Fioravanti il killer del marito, e si seguì la pista debolissima di un piccolo appalto di mafia.
Mi è sempre sembrato strano che un Presidente della Regione potesse essere ucciso per un appalto relativo alla costruzione di sei scuole. Ma non c’è dubbio che si è sempre voluto trovare un movente mafioso per omicidi che potevano rispondere anche ad altre logiche. Anche per quanto riguarda il Generale dalla Chiesa, nominato Prefetto di Palermo. Se la mafia avesse voluto uccidere tutti i Prefetti di Palermo…
E il suo posto, lo prese Emanuele De Francesco, ex capo del Sisde. E Bruno Contrada è stato numero 3 del Sisde. E il Sisde compare più volte: persino nelle indagini su via D’Amelio.
I servizi segreti in questo Paese sono sempre stati determinanti. Il potere politico non si è mai mostrato capace di domarli. Fino al Caso Pollari. Prodi lo ha nominato al Consiglio di Stato.
Proprio come Vincenzo Parisi, ex capo della polizia al tempo delle stragi ed altro ex capo del Sisde. E la questione della collaborazione tra mafia e Stato? Ora s’indaga su una trattativa. Anzi: la trattativa.
Noi l’avevamo sfiorata, quella collaborazione. Ma gli strumenti a nostra disposizione erano quelli di una magistratura con poche armi, con una legislazione normale. Basti pensare alla tecnica delle intercettazioni, come si è evoluta. Noi ce li sognavamo, i tabulati e le localizzazioni GPS. E l’apparato giudiziario, aggiungo, era quel che era. Basti rileggere i diari di Rocco Chinnici. Falcone poi non aveva gran fiducia nel reato associativo, nel 416 bis: preferiva fosse riscontrato da reati specifici. Voleva fatti concreti. Erano certo tempi diversi, che impedivano di andare a fondo di determinate complicità tra mafia e pezzi dello Stato, a pena dell’interruzione di ogni collaborazione reale. Falcone ne era consapevole. Era molto difficile andare a fondo di determinati filoni d’indagine. Era un sistema – quello delle relazioni occulte – che funzionava perfettamente. Arrestare un uomo che fosse una tessera del mosaico, avrebbe significato trovarsi addosso l’intero sistema. Ricordo di un mio amico, un magistrato galantuomo che lavorava a Roma e indagava sul terrorismo neofascista: chiamava a deporre dei graduati delle varie forze dell’ordine e quelli, semplicemente, non si presentavano. Cosa devo fare, mi chiedeva?
Il sistema blindava i suoi uomini più esposti. Poi qualcosa è cambiato. È arrivato il ’92. Tangentopoli. Oliviero Tognoli – snodo importante del riciclaggio di denaro sporco, a Milano - era stato indagato anni prima, a Palermo. Dopo il fallito attentato dell’Addaura, Falcone dichiara: “(Non) sembra da trascurare il fatto che proprio i colleghi svizzeri (Carla del Ponte e Claudio Lehman, suoi ospiti all’Addaura e con lui bersagli dell’esplosivo, ndr) in quel periodo stavano occupandosi di indagini soprattutto finanziarie riguardanti notissimi esponenti della mafia siciliana. In quel procedimento, allora in corso in Svizzera, non tutto è chiaro circa i ruoli di Vito Roberto Palazzolo, Leonardo Greco, Salvatore Ammendolito e Oliviero Tognoli; né credo che soprattutto quest’ultimo abbia detto per intero la verità sui suoi collegamenti con la mafia siciliana su inquietanti vicende riguardanti la sua fuga da Palermo subito dopo l’emissione di un ordine di cattura nei suoi confronti (…)”.
Si scopre questo canale di riciclaggio: un canale unico, per tangenti e mafia. L'inchiesta Mani Pulite aveva dei legami con l’Isola. C’è Raul Gardini che d’improvviso compra Pizzo Sella, terreno di una delle più grandi speculazioni di quel tempo, a Palermo. E si suicida prima di dire quel che sa. S’era suicidato anche Michele Sindona. Il quale non era un uomo di mondo: era uno che aveva detto cose simili a quelle pronunciate da Gaspare Pisciotta prima del suo “suicidio” (ex braccio destro del bandito Salvatore Giuliano, ndr). Molte cose non verranno mai fuori. Nessuno ha interesse a farle venire fuori.
Dai nuovi processi sulle stragi potrebbe venir fuori la verità, finalmente?
Io ho fiducia di sì. Se all’interno di questo Procure si vuol cercare qualcosa di nuovo. Gli archivi non bastano. La frase “aprite gli archivi” non ha senso senza una diversa intelligenza degli eventi.
La conversazione finisce, e Giuseppe Di Lello mi suggerisce un libro. Un diario, che racconta del funzionamento di certi poteri. E capisco che la mafia è sempre la mafia, ma non ha più il monopolio della violenza. Il potere è altrove.
Il nostro contesto interpretativo è l’Italia (e già “contesto” è un termine letterario, per via del romanzo di Leonardo Sciascia: ambiguo per eccellenza, multiforme, e dunque adatto all’investigazione).
Anni fa, in Italia, dietrologi erano coloro che intravedevano, dietro i fatti di sangue e i rivolgimenti politici, delle trame tessute da certi poteri che agivano nell’ombra: servizi segreti italiani e stranieri, poteri economici e politici, lobbies e confraternite.
Ora, dinanzi all’esito di indagini giudiziarie e inchieste giornalistiche sulle stragi del ’92, bisogna chiedersi: che significa dietrologia? Furono dietrologi coloro che si esercitarono nel sospetto, coloro che rimasero insoddisfatti delle indagini e delle verità di Stato?
Vi fu una trattativa, dicono pm e testimoni, che coinvolse uomini della mafia e dello Stato: mentre Cosa Nostra preparava il tritolo per Capaci e Via d’Amelio.
Paolo Borsellino sapeva che sarebbe stato ucciso. Era stato avvertito. Si era preparato alla morte.
Si dice che uomini dello Stato fossero “punciuti”: che fossero passati per l’iniziazione mafiosa, che prevede una puntura di spillo, su un dito, e la fuoriscita del sangue, da cospargere su un’immagine sacra, che brucerà come le carni dell’iniziato, se tradirà.
Si dice che uomini delle istituzioni abbiano depistato, sin dall’inizio, le indagini sulle stragi.
Si dice che Falcone e Borsellino siano stati accompagnati dinanzi al plotone d’esecuzione.
Bisogna chiedere ai testimoni, ai sopravvissuti: che è successo?
Giuseppe Di Lello è stato giudice istruttore al tempo di Rocco Chinnici: testimone, dunque.
È rimasto nel pool antimafia pure al tempo di Antonino Caponnetto, con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Poi, dal 1999, è stato deputato europeo e senatore, per Rifondazione Comunista. Ora è in pensione.
Giuseppe Di Lello ha assistito, ha preso parte; ha visto e pianto. È un esile e roccioso abruzzese di Villa Santa Maria, nel Teatino; arrivato in Sicilia dopo il concorso, nel 1971, e rimasto in Sicilia, per amore e per passione civile. Me lo ricordo, in una fotografia in bianco e nero: ad una camera ardente. Dinanzi ad una bara. In toga. Il volto più magro del solito. Un’espressione sofferente, dietro gli occhiali spessi. Forse per la morte di Chinnici, o di Falcone, di Borsellino.
Ma è possibile? Una trattativa tra mafia e Stato?
Devo fare una premessa. Sono sempre stato restio ad inseguire un complotto mondiale. Contrario ad immaginare una storia d’Italia ispirata al meccanismo servizi-mafia-complotti. La storia d’Italia è stata costruita anche da tante forze democratiche e sindacati che la mafia hanno sempre combattuto. Però bisogna dire che il depistaggio del processo Borsellino è emblematico. Non è detto che sia stato tutto dovuto al solo Questore di Palermo Arnaldo La Barbera. È solo un esempio, naturalmente. Dietro la strage di via D’Amelio, ci doveva esser dietro qualcuno che non fosse solo mafia. La Barbera era un personaggio abbastanza equivoco. Era a libro paga dei servizi. Vista retrospettivamente, questa vicenda dell’agenda e dell’invenzione di Scarantino comincia a spiegare che dietro questi fatti non poteva esserci solo mafia. Dando ragione a Falcone, che a proposito del fallito attentato contro di lui e due giudici svizzeri all’Addaura parlò di “menti raffinatissime”. Falcone aveva capito tutto. Anche che Salvo Lima non era un mafioso, nel senso che non era “punciuto”. Falcone lo disse anche a Ciriaco De Mita, che allora era segretario della DC. Lima era un punto di raccordo tra la mafia e la politica. Ma non aveva il calibro del mafioso. E lo sapevano anche i mafiosi. Forse, era anche un po’ millantatore, avendo offerto una specie di assicurazione sull’aggiustamento dei processi. E prendeva i voti dei mafiosi.
Forse l’assassinio di Lima fu un colpo tirato a freddo contro Giulio Andreotti: non doveva essere eletto Presidente della Repubblica. E Capaci, potrebbe esser stato il colpo di grazia.
Fu a mio parere un fatto accessorio, un danno collaterale. L’attentato di Capaci era stato preparato con anticipo. Così come quello di via D’Amelio, nonostante l’accelerazione decisa dopo la morte di Falcone.
E gli Stati Uniti? Non avevano mai visto in Andreotti un interlocutore credibile. Troppo filo arabo, e in un momento molto difficile.
Penso che gli Usa avessero l’obiettivo di combattere la mafia. Tennero in custodia per noi Buscetta e Marino Mannoia, facendoci un gran favore. E Buscetta parlò dei Salvo e di Andreotti.
Gli Usa però non cedettero mai un altro loro detenuto: Gaetano Badalamenti. E Badalamenti, contrariamente a Buscetta, era stato un capo: il capo di Cosa Nostra in Italia. E se avesse parlato Badalamenti?
Avrebbe fatto luce sui reali rapporti tra mafia e politica. Buscetta parlò solo, e bene, di mafia militare. Ma tenne per sé molti segreti. E tacque di sé. Non era stato un capo, ma forse, immagino, aveva ucciso, con le sue mani. Si pensa che lo abbia fatto. Era uno degli affiliati ad un clan sanguinoso, quello dei La Barbera. Ma di questo, con noi, non parlò mai.
Più volte ho pensato a Cosa Nostra come ad un’agenzia criminale, sul mercato, e non come ad un’entità criminale a se stante.
Le due cose non sono in contraddizione. Credo che la mafia abbia agito anche su impulsi esterni ma badando sempre ai suoi interessi.
Parliamo di omicidi politici. Nel ’78, le BR e chissà chi altri uccidono Aldo Moro. Nel ’79, la mafia – e chissà chi altri – uccide Michele Reina. Nell’80, tocca a Piersanti Mattarella. Tutti e tre, democristiani. Tutti e tre, protagonisti di aperture al PCI: a Roma, a Palermo, alla Regione. Tutti e tre, morti. Con loro, finisce la politica di solidarietà nazionale.
Non c’è dubbio che se devi uccidere qualcuno di importante in Sicilia non puoi non passare per quest’organizzazione criminale. E dunque è possibile che se altri volessero la morte di Reina e Mattarella, siano passati per la mafia.
Si è sempre detto, però, che per Reina e Mattarella vi era un movente mafioso: non un semplice uso strumentale della mafia da parte di terzi. E i depistaggi cominciano subito. Per Reina, s’assistette ad una messinscena con finte rivendicazioni terroristiche, da parte di BR e Prima Linea: e le indagini s’incagliarono. Per Mattarella, fu cassata la testimonianza della vedova, testimone oculare dell’assassinio, che aveva riconosciuto nel terrorista nero Giusva Fioravanti il killer del marito, e si seguì la pista debolissima di un piccolo appalto di mafia.
Mi è sempre sembrato strano che un Presidente della Regione potesse essere ucciso per un appalto relativo alla costruzione di sei scuole. Ma non c’è dubbio che si è sempre voluto trovare un movente mafioso per omicidi che potevano rispondere anche ad altre logiche. Anche per quanto riguarda il Generale dalla Chiesa, nominato Prefetto di Palermo. Se la mafia avesse voluto uccidere tutti i Prefetti di Palermo…
E il suo posto, lo prese Emanuele De Francesco, ex capo del Sisde. E Bruno Contrada è stato numero 3 del Sisde. E il Sisde compare più volte: persino nelle indagini su via D’Amelio.
I servizi segreti in questo Paese sono sempre stati determinanti. Il potere politico non si è mai mostrato capace di domarli. Fino al Caso Pollari. Prodi lo ha nominato al Consiglio di Stato.
Proprio come Vincenzo Parisi, ex capo della polizia al tempo delle stragi ed altro ex capo del Sisde. E la questione della collaborazione tra mafia e Stato? Ora s’indaga su una trattativa. Anzi: la trattativa.
Noi l’avevamo sfiorata, quella collaborazione. Ma gli strumenti a nostra disposizione erano quelli di una magistratura con poche armi, con una legislazione normale. Basti pensare alla tecnica delle intercettazioni, come si è evoluta. Noi ce li sognavamo, i tabulati e le localizzazioni GPS. E l’apparato giudiziario, aggiungo, era quel che era. Basti rileggere i diari di Rocco Chinnici. Falcone poi non aveva gran fiducia nel reato associativo, nel 416 bis: preferiva fosse riscontrato da reati specifici. Voleva fatti concreti. Erano certo tempi diversi, che impedivano di andare a fondo di determinate complicità tra mafia e pezzi dello Stato, a pena dell’interruzione di ogni collaborazione reale. Falcone ne era consapevole. Era molto difficile andare a fondo di determinati filoni d’indagine. Era un sistema – quello delle relazioni occulte – che funzionava perfettamente. Arrestare un uomo che fosse una tessera del mosaico, avrebbe significato trovarsi addosso l’intero sistema. Ricordo di un mio amico, un magistrato galantuomo che lavorava a Roma e indagava sul terrorismo neofascista: chiamava a deporre dei graduati delle varie forze dell’ordine e quelli, semplicemente, non si presentavano. Cosa devo fare, mi chiedeva?
Il sistema blindava i suoi uomini più esposti. Poi qualcosa è cambiato. È arrivato il ’92. Tangentopoli. Oliviero Tognoli – snodo importante del riciclaggio di denaro sporco, a Milano - era stato indagato anni prima, a Palermo. Dopo il fallito attentato dell’Addaura, Falcone dichiara: “(Non) sembra da trascurare il fatto che proprio i colleghi svizzeri (Carla del Ponte e Claudio Lehman, suoi ospiti all’Addaura e con lui bersagli dell’esplosivo, ndr) in quel periodo stavano occupandosi di indagini soprattutto finanziarie riguardanti notissimi esponenti della mafia siciliana. In quel procedimento, allora in corso in Svizzera, non tutto è chiaro circa i ruoli di Vito Roberto Palazzolo, Leonardo Greco, Salvatore Ammendolito e Oliviero Tognoli; né credo che soprattutto quest’ultimo abbia detto per intero la verità sui suoi collegamenti con la mafia siciliana su inquietanti vicende riguardanti la sua fuga da Palermo subito dopo l’emissione di un ordine di cattura nei suoi confronti (…)”.
Si scopre questo canale di riciclaggio: un canale unico, per tangenti e mafia. L'inchiesta Mani Pulite aveva dei legami con l’Isola. C’è Raul Gardini che d’improvviso compra Pizzo Sella, terreno di una delle più grandi speculazioni di quel tempo, a Palermo. E si suicida prima di dire quel che sa. S’era suicidato anche Michele Sindona. Il quale non era un uomo di mondo: era uno che aveva detto cose simili a quelle pronunciate da Gaspare Pisciotta prima del suo “suicidio” (ex braccio destro del bandito Salvatore Giuliano, ndr). Molte cose non verranno mai fuori. Nessuno ha interesse a farle venire fuori.
Dai nuovi processi sulle stragi potrebbe venir fuori la verità, finalmente?
Io ho fiducia di sì. Se all’interno di questo Procure si vuol cercare qualcosa di nuovo. Gli archivi non bastano. La frase “aprite gli archivi” non ha senso senza una diversa intelligenza degli eventi.
La conversazione finisce, e Giuseppe Di Lello mi suggerisce un libro. Un diario, che racconta del funzionamento di certi poteri. E capisco che la mafia è sempre la mafia, ma non ha più il monopolio della violenza. Il potere è altrove.
venerdì 29 giugno 2012
BALOTELLI E LA MAMMA
La più bella immagine, finora, di questi Europei. Più dei gol e delle esultanze; più delle acrobazie e delle pose scultoree. Per la tenerezza. Per il futuro. Per tutti noi.
giovedì 28 giugno 2012
GLI ANNI RUGGENTI DE L'ORA
Nell’anno di grazia 1900, anno di esposizioni universali e di grandi entusiasmi borghesi, il mondo girava ancora per il suo verso, nel proustiano ordine degli anni e dei mondi. C’erano ancora le avanguardie: poetiche, politiche, persino giornalistiche.
A Palermo, il commendator Vincenzo Florio, armatore e imprenditore vinicolo a Marsala, per l’omonimo concorrente dell’inglesissimo Sherry, fondò un giornale che nel nome, inciso a caratteri floreali, liberty, aveva già un programma: L’Ora, come dire l’ora di muoversi, di cambiare tutto.
In primisi, a dirigerlo, fu il calabrese Vincenzo Morello, inteso Rastignac, e in seguito venne anche l’aquilano Edoardo Scarfoglio, che maggior celebrità avrebbe acquisito alla guida del Mattino di Napoli.
I primi vent’anni trascorsero sereni: Palermo era Capitale, nel Mediterraneo. Poi venne il fascismo che, dice Flaiano, “conviene agli italiani perché è nella loro natura e racchiude le loro aspirazioni, esalta i loro odi, rassicura la loro inferiorità”.
Male però incolse al Regime mussoliniano e ai suoi podestà locali, che per censura prima spensero e poi riaccesero le rotative, affidando infine, per imprudenza, l’interruttore allo sportivissimo cronista Nino Sofia, che per sport, appunto, giocò alla fronda, al dissenso.
Dopo la seconda grande guerra, la vedova dell’ultimo editore, Sebastiano Lo Verde, vendette la testata, il palazzo e le macchine ad una società guidata da Amerigo Terenzi, l’editore rosso, legato direttamente al Partito Comunista Italiano. E un giovane cronista politico del Paese, Vittorio Nisticò, fu nominato direttore. Un contratto ventennale, il suo.
“Ai lettori, dunque, salute! Noi non intendiamo di fare o i maestri o le guide: ambiziosi da vecchi o da sediziosi, ma aspiriamo a diventare, modestamente e semplicemente, i segretari della pubblica opinione siciliana”. Citava il suo predecessore Rastignac, e un poco mentiva, Nisticò, nel suo corsivo programmatico, dettato al primo piano d’una grigia palazzina in purissimo stile casadelpopolo, addossata al cuore finanziario della Città, che per lapsus urbanistico sorgeva in piazzale Ungheria.
Altro che segretari della pubblica opinione siciliana! I frequentatori di quella palazzina squadrata sposarono un sicilianismo eretico, quello dei Varvaro. Dal frondismo di destra si passò al frondismo di sinistra. Giacobini sarebbero stati, preti spretati per quegli ortodossi che al mattino si bagnavano nell’acqua della Moscova.
Quando il mondo girava per il suo verso, coi comunisti e i fascisti e in mezzo la Democrazia Cristiana, ogni inchiesta pareva un eroico abbordaggio nei mari della malapolitica. Ogni titolo, era un trofeo, da strillare nei pirateschi vicoli di Palermo, una città che pareva la salgariana Maracaibo, fra i pescherecci ancorati al porto della Cala e i banchi di pesce e frutta al popolare mercato di Ballarò.
Vittorio Nisticò ha raccontato il suo giornale in mille pagine, e nei due volumi, pubblicati da Sellerio, ci si perde e ritrova, ed è bene che il lettore abbandoni ogni pregiudizio, prima di avventurarsi nella lettura, e in quel labirinto che era Palermo mezzo secolo fa.
Accadeva in Sicilia. Gli anni ruggenti dell’<> di Palermo. E’ il romanzo civile di un calabrese, Nisticò, che guardò giustamente alla Sicilia come al continente, e l’aria che ne assaporò fu sempre di mistero. Ed è come se, con tutto il rispetto, un vecchio corsaro avesse deciso di aprire il forziere, lasciando di stucco i poveri contemporanei con i frutti del suo cimento: pietre di mille colori e metalli preziosissimi.
Il Vascello di Nisticò per vent’anni traversò quei sette mari, infestati di pesci lupara e pesci tritolo, e tra le ondate perse un nocchiero, come Mauro De Mauro, ucciso a Palermo dalla mafia, e qualche marinaio, Giovanni Spampinato, ammazzato a Ragusa, e Cosimo Cristina, freddato a Termini Imerese.
Era già un tempo che annunciava il verso contrario, come nel ‘59 profetizzò Flaiano: “L’evo moderno è finito. Comincia il medio evo degli specialisti. L’arte è inutile, la poesia superata dagli avvenimenti. La musica è quella dei pianeti rotanti negli spazi, la filosofia finalmente si confonde nella fisica. Continuare il proprio lavoro per il progresso dell’umanità? Ah, questo è troppo!”.
Meno intellettuali, i giornalisti, e anche meno pirati: più impiegati, semplicemente, negli uffici redazione.
Dal forziere, Nisticò estrae i suoi ricordi, della volta che L’Ora in qualche modo propiziò il governo regionale di Silvio Milazzo, tutti insieme dal Msi al Pci, tutti tranne la Dc. Strana occasione, il menàge tra rossi e neri: un’alleanza talmente anomala che - arrischia Nisticò – fu forse benedetta da un pezzo di Vaticano (Papa Roncalli era stato appena eletto); una bomba che doveva esplodere a Piazza del Gesù e invece non riuscì, per uno scandalo forse orchestrato del Sifar, come suggerì anni dopo il generale De Lorenzo.
Auspicava Nisticò che quel gesto inconsulto spianasse “la via per un cammino autonomo civile e rinnovatore della Sicilia” (24 ottobre 1958). Cinquecento giorni dopo, il miraggio di un governo regionale slegato dagli equilibri politici nazionali svanì. Da allora è stato rincorso mille volte.
Racconta ancora Nisticò di quella volta che il primo capo dei capi di Cosa nostra, Lucianeddu Liggio, offeso da un titolo irriverente, stampò una bomba vera, 4 chili di tritolo sotto il portone di piazzetta Napoli. E la politica dei quartier generali, a sua volta offesa dal sostegno del giornale al milazzismo, si voltò a guardare dall’altro lato.
Poi vennero i moti operai dell’8 luglio, al confronto dei quali i fatti di Genova e del G8 paiono palicu, stuzzicadenti. A Palermo costarono tre morti. L’Ora finì denunciato, d’iniziativa della Procura, per vilipendio del governo (di Tambroni).
Vennero pure i dibattiti sul Gattopardo, con Sciascia e Rea, e quel Vittorini che niente aveva capito dell’opera del Principe. E la Targa Florio, e il processo a Danilo Dolci, e la caduta di Genco Russo, e lo scempio della Città dei Templi, e i ragazzi del ’68, e la strana morte di Enrico Mattei.
Fu levatrice di cronisti, L’Ora, e custode di talenti. Angelo Arisco, Orazio Barrese, Letizia Battaglia (mastra di fotografia, che poi vinse il pulitzer della fotografia, il premio Eugene Smith), Roberto Baudo, Mino Bonsangue, Giacinto Borelli, Bruno Carbone, Nicola Cattedra, Felice Chilanti, Marcello Cimino, Roberto Ciuni, Aniello Coppola, Aldo Costa, Angela Fais, Mario Farinella, Etrio Fidora, Franco Foresta Martin, Giacomo Galante, Mario Genco (che a questa fatica di Nisticò ha collaborato), Mario Giordano, Tano Gullo, Salvo Licata, Gianni Lo Monaco, Alfonso Madeo, Kris Mancuso, Gabriello Montemagno, Gilberto Nanetti, Franco Nicastro, Gino Pallotta, Enzo Perrone, Giovanni e Tanino Rizzuto, Giulio Roberti, Giuliana Saladino, Alberto Scandone, Ebe Sesto, Marcello Sofia, Guido Valdini e Nicola Volpes.
Fu pure palestra, e tanti si fecero le ossa, prima di andarsene in Italia. Antonio Calabrò, Giuseppe Cerasa, Francesco La Licata, Francesco Merlo, Sebastiano Messina, Giampiero Mughini, Sergio Sergi, Marcello Sorgi, Giuseppe Sottile, Alberto Stabile, Bianca Stancanelli.
Marcello Sorgi, che firma l’introduzione ai 2 volumi, e oggi dirige La Stampa di Torino (forse a titolo di risarcimento per centomila emigranti Fiat), era il figlio dell’avvocato del giornale, Nino Sorgi, e il buio e il puzzo della tipografia li respirò da ragazzino. “E fui presto introdotto nel salone della rotativa: una specie di locomotiva stanca, ansimante, rumorosa, regolata con furia, a colpi di mazza, da una squadra affollata di operai, e protesa verso una enorme bocca sdentata dalla quale, incredibilmente, cominciavano a venir fuori copie nitidissime di giornale”.
Mille furono poi gli intellettuali e i collaboratori del giornale. Critici d’arte e teatrali, fotografi, musicologi, registi, scrittori, sociologi. E tra di loro, Sebastiano Addamo, Vincenzo Consolo, Danilo Dolci, Beppe Fazio, Franco Grasso, Gioacchino Lanza Tomasi, Michele Perriera, padre Ennio Pintacuda (gesuita di gran razza, che difatti Cossiga voleva rispedire in Paraguay), Enzo Sellerio e Piero Violante. A partire dal 24 marzo del ’55, pure Leonardo Sciascia raccontò di libri e di zolfare, a caratteri di piombo. Nanà faceva a piedi quattro rampe di scale e arrivato nello stanzone si cavava dalla tasca della giacca un foglio ripiegato, e al capo cronista diceva né più né meno: “Non so se va bene, vedete voi”, che così, con poche e modestissime parole, ragionava il Maestro.
Altri libri ci sono, altri due piccoli tesori di Sellerio, che raccontano di quegli anni ruggenti. Una biografia di Marcello Cimino (Vita e morte di un comunista soave), composta in lapislazzuli e turchesi da quell’artigiano finissimo che è Michele Perriera, tra i fondatori del Gruppo ‘63, e la riedizione di Terra di rapina, vecchio libro inchiesta di Giuliana Saladino, moglie di Cimino.
Ne è passato di tempo. Nessuno si è indignato quando, alla fine del secolo scorso, correva il 1999, il Time scrisse che il boss Lucky Luciano, gran diplomatico dello sbarco alleato in Sicilia, era da considerarsi uno tra i cento “costruttori e titani” dell’economia mondiale del secolo, accanto a Ford, Disney, Gates e Rockfeller.
Nessuno s’indignò, tranne appunto in questi 2 volumi Nisticò, titolare di una duecentina di querele, guadagnate sul campo da Direttore un poco frondista.
E il Direttore dedica poche righe alla fine del giornale, nel ’92, quando la Nuova Editrice Meridionale, emanazione dei post comunisti del Pds, riuscì dove manco fascismo e mafia avevano potuto, ad astutare la candela accesa da don Vincenzo Florio.
Forse, la ruggine si mangiò le rotative a saldo dell’antico vezzo di molti redattori di quel giornale: l’andar come salmoni, controcorrente.
KUFRA
Era un luogo di sfruttamento e di sofferenza, Kufra. Stazione di transito dei migranti che partivano dal cuore dell’Africa e attraverso la Libia cercavano di arrivare ai porti che conducevano alla Sicilia: al mare, a quel Mediterraneo che ha inghiottito migliaia di persone, negli ultimi anni. Poi, una sorta di campo profughi, simile ad un lager, secondo i racconti delle organizzazioni non governative.
Avevo trasformato Kufra in Kenafra, nel mio romanzo “Questo è un uomo”. Avvicinandolo ad altri campi e ad altri tempi in cui la dignità dell’uomo era calpestata e derisa, per usare un’espressione antica: avvicinandolo ad Auschwitz Birkenau, a Bergen Belsen, a Treblinka.
Avevo riletto Primo Levi, che nel 1987 - ben 42 anni dopo la liberazione da Auschwitz ad opera dei militari sovietici - si suicidò, non reggendo al dolore e alla colpa che s’ingenerò nei Salvati, in coloro che sopravvissero, a prezzo di indicibili sofferenze e di piccoli tradimenti: il pane negato all’affamato e il capo chino dinanzi al compagno che andava alle docce (sapemmo poi, affumicate di Zyklon B, un veleno micidiale a base di cianuro) e ai forni crematori.
Con che animo leggo dunque, in una cronaca di giornale, che l’Italia ha ribadito con la Libia i termini di un accordo di respingimento in mare dei migranti e l’utilizzo di Kufra: di quel campo, per trattenere i migranti.
Sono tempi difficili, me ne rendo conto: economicamente e socialmente. E so anche che l’Europa scarica il peso dell’emergenza migratoria in Africa sui Paesi cerniera, l’Italia innanzitutto; e che in Libia vi è un tentativo democratico, dopo la rivoluzione che ha liquidato Gheddafi ed il suo clan.
Mi chiedo, tuttavia, se non vi fossero altre vie da percorrere: vie che non passassero per Kufra.
I racconti dei migranti passati per quell’Oasi, dicono di dolore e di colpa: proprio come ad Auschwitz Birkenau. Di violenze e di stupri, perpetrati con il potere delle armi.
Il nostro Paese, che ha conosciuto l’orrore della guerra e delle persecuzioni, non può dire: Non sapevo.
Il mondo intero, quando si riseppe delle sofferenze nei lager, disse: Non sapevo.
Ma sono passati 67 anni.
Elie Wiesel giunse ad affermare che Dio doveva esser morto (come predetto da Nietzche), perché fosse concesso alla barbarie nazista di massacrare gli ebrei, il popolo prediletto da Dio.
Racconta Moni Ovadia di un sopravvissuto che all’uscita da un campo di concentramento urlò ad un rabbino: “Il tuo Dio è morto”. E il rabbino: “Può darsi, è probabile, ma l’importante è che sia nato l’uomo”.
Penso che ad addormentarsi, talvolta, siano la memoria e la pietà degli uomini.
Ho letto anche una buona notizia.
L’Unione Europea ha appena varato un piano strategico per combattere la schiavitù e il trafficking: il traffico di esseri umani. Milioni di persone: 21, secondo l’Organizzazione In-ternazionale del Lavoro (e un quarto di essi, minorenni); vittime di lavoro forzato, di stu-pri, di accattonaggio organizzato. Alcune misure dovranno essere adottate nei prossimi anni. Cinque le priorità: prevenzione, identificazione, protezione e supporto delle vittime, attività repressive.
Ogni Paese avrà i suoi compiti, e dovrà collaborare con gli altri Paesi europei: un milione e mezzo di quei 21, infatti, risiedono nei Paesi sviluppati, e dunque anche in Europa.
Kufra, però, resta: e sarà utilizzato da Italia e Libia per il respingimento dei migranti.
A nessuno sarebbe venuto in mente, dopo il 27 gennaio del ’45, data della liberazione di Auschwitz ad opera dei militari sovietici, di riutilizzare quel campo: se non a fini di memoria.
Mi chiedo se non si possa, se non si debba, rimediare.
UOMINI DI LAMPEDUSA
Lavoro in Sicilia, e mi è capitato spesso di raccontare storie di migrazioni.
Ricordo la storia della Cap Anamur, nel 2004: una nave tedesca che raccoglieva nel Mediterraneo i sopravvissuti alle navi negriere e ai gommoni in avaria. Il comandante - che aveva salvato 37 sudanesi, poi espulsi -, fu arrestato al suo arrivo a Porto Empedocle. Ricordo di aver visitato la nave e le sue stive bene ordinate, fuori delle acque territoriali. Avevo sorvolato la Cap Anamur con un elicottero, alla notizia dell’Sos lanciato per ottenere ospitalità in un porto siciliano; poi, ero arrivato a bordo con un gommone non so più se di Emergency o di Medecins sans frontieres.
Ricordo la mia amarezza.
Quando hai finito le interviste e l’operatore ha terminato di girare le altre immagini che serviranno a montare il servizio – totali, particolari, dettagli -, stringi le mani, saluti e, con un po’ d’imbarazzo, vai via. Non hai scuse, e lo sai.
Quegli uomini hanno detto delle cose al mondo, e non a te; vorrebbero che quelle frasi arrivassero a casa loro, con i loro volti, per le madri, i fratelli, gli amici.
Tu non puoi assicurargli niente: solo un minuto e mezzo di buona volontà, ad ora di pranzo, o di cena.
Quando incontro qualcuno con una storia dolorosa – come può esserlo una fuga dal Sudan, dal Ciad, dalla Costa d’Avorio, dalla Somalia, dall’Eritrea – so già che lo deluderò.
Nel 2011, le storie da raccontare sulle migrazioni sono state molte, e io le ho apprese dalle agenzie di stampa, o dai post di pochi ostinati sui social network.
Le storie su Lampedusa riguardavano mancati approdi e rivolte.
Non vado più tanto in giro, oramai: raramente, mi allontano da Palermo. Uso il telefono e il computer, per il mio lavoro giornalistico.
Al mattino, all’alba, fuori è ancora buio, sei al lavoro e scavi con la tastiera nella rete.
A volte, trovi la notizia di un avvistamento.
Vai testardamente in cerca di conferme o di smentite. Di dettagli.
Dieci, cinquanta, cento persone disperse, in un punto radar in mezzo al mare. Hanno lanciato un Sos. Poi, più nulla.
I naufraghi partono dai porti libici dopo un’odissea attraverso il deserto e i campi profughi: luoghi di violenze indicibili. E dopo lunghe settimane, mesi d’attesa, s’imbarcano e si perdono in mare.
A volte, li ritrovano, li soccorrono: gli italiani, e qualche volta anche i maltesi. Fanno la conta dei vivi e dei morti. Di fronte, si trovano dei sopravvissuti.
La differenza tra italiani e maltesi non è da poco.
A volte gli italiani li trattengono, quei sopravvissuti, se hanno diritto a chiedere asilo. Dovrebbero esser liberi, nei centri nei quali attendono per mesi il pronunciamento della commissione incaricata di valutare le loro richieste, ma di frequente restano chiusi a doppia mandata, come nei campi d’identificazione e di espulsione.
Fatto sta che nel 2011, complici le rivoluzioni del Maghreb e la pressione decisa sull’Italia traditrice dal clan Gheddafi, a Lampedusa sono arrivati in cinquantamila.
Non eravamo preparati. Quel che è successo dopo, lo testimonia.
A febbraio, in pochi giorni, erano sbarcati in quattromila. Il Centro di prima accoglienza, chiuso per eccesso d’ottimismo, era stato riaperto in tutta fretta.
Gli sbarchi sembravano non fermarsi mai.
Il 20 settembre, il Centro ospitava 1200 tunisini esasperati. D’improvviso, i più violenti hanno appiccato il fuoco in diversi punti dell’edificio, usando i materassi. Il fumo si è levato altissimo. Nero. E dal Centro, quel fumo aspro e irrespirabile è finito in Paese.
La gente scappava. I migranti e i lampedusani.
Le prime immagini sapevano di tragedia.
All’indomani, nuova rivolta, nello stadio comunale, vicino al porto, utilizzato - dopo la devastazione del Centro - per un centinaio di tunisini. Alcuni migranti hanno minacciato di far esplodere delle bombole di gas. La polizia è intervenuta in assetto antisommossa, a suon di cariche e manganelli.
Poi, anche i lampedusani si sono rivoltati: lanciando delle pietre, urlando. E si è temuto che alla violenza degli uni, dei tunisini, seguisse la violenza incontenibile degli altri, degli isolani.
Chi avrebbe potuto frenarla, quella moltiplicazione di infelicità?
I poliziotti, forse? No, troppo pochi, con turni massacranti e disagi insopportabili.
E’ finita che Lampedusa è stata svuotata con le navi: normali navi turistiche, accuratamente devastate da chi era stato spinto nelle grandi sale, con pochi bagni sporchi per migliaia di persone alla volta.
Lampedusa è un’isola generosa, e ha perso una stagione turistica. Berlusconi ha promesso fondi e leggi speciali.
Secondo Save the Children, nel 2011 sono arrivati a Lampedusa 2.737 minorenni: 2.599 da soli, senza famigliari. Un migliaio di loro ha fatto la trafila dalle strutture di assistenza fino alle case alloggio. In centosei sono fuggiti (metà da Calabria e Campania, metà dalla Sicilia), e non se ne sa più nulla.
Nel 2009, ho scritto un romanzo per dire della tragedia di chi parte da villaggi poverissimi e muore lungo la strada del sogno. Ho letto, per immedesimarmi e vivere quella fuga senza luce, i reportage di Fabrizio Gatti, i dossier delle ONG pubblicati su Internet e, infine, ho riletto i libri di Primo Levi. Ho chiamato il mio romanzo “Questo è un uomo”.
In questa, che è forse la più grande migrazione della storia umana, i morti sono tanti. Oltre diciottomila, quelli censiti dal 1988. Come i morti di Portopalo di Capo Passero. E gli altri? E i morti lungo la strada, nel deserto africano? Uccisi dalla fame, dai predoni. E i morti nei campi di detenzione? E gli altri morti in mare? Di quanti altri non si è mai saputo nulla?
Il 17 gennaio del 2012, Fortress Europe, un blog straordinario sui migranti, ha raccontato di 55 dispersi libici sulla rotta per Lampedusa.
Quando cammino per strada, penso che quelli che vedo – volti neri o nerissimi, dai tratti scavati o più sottili, di una parte o di un’altra dell’Africa – sono in realtà solo dei sopravvissuti, e si portano dietro immagini e ricordi di morte.
PIO LA TORRE E GLI ALTRI
Qual è il nesso tra molti delitti politico mafiosi siciliani? Ad esser colpiti, son stati degli uomini che avevano “capito”, e che avrebbero potuto scardinare il “Sistema” di alleanze tra la mafia ed altri poteri abituati ad agire nell’ombra a difesa di colossali interessi: economici e geopolitici.
Pio La Torre fu ucciso, insieme alla sua guardia del corpo, Rosario Di Salvo, il 30 aprile dell’82: crivellato di colpi da un commando mafioso: oramai, questa è verità giudiziaria, così come il fatto che fu la Cupola ad ordinare quell’omicidio.
Ma la domanda, ovvia, è se la mafia abbia agito da sola o per conto terzi (e se, meno ovviamente, questa sua caratteristica, l’agire per conto terzi, non sia la condizione essenziale del suo agire).
La Torre aveva conosciuto la mafia: veniva da una borgata di Palermo; giovanissimo aveva aderito al Pci, organizzando i braccianti per occupare le terre incolte, e attirandosi le minacce, non troppo velate, del capomafia della zona (il papà di quel Leonardo Vitale, il primo pentito di mafia in Italia, che molti anni dopo avrebbe raccontato Cosa Nostra dal di dentro); era stato in Commissione Antimafia per tre legislature, insieme a Cesare Terranova, ucciso nel ’79, ed aveva scritto una proposta di legge per colpire al cuore Cosa Nostra, introducendo il reato di associazione di stampo mafioso e, sempre sul modello americano, consentendo l’aggressione ai capitali mafiosi.
Ma, fate attenzione, La Torre era stato anche quell’alto dirigente comunista che, in una fase cruciale della storia siciliana, aveva scelto di lasciare gli incarichi nazionali di partito e di tornare nella sua Isola, da segretario regionale del Pci. Nel 1981, aveva dato il via alla costruzione del più esteso movimento pacifista d’Europa: schierato, unitariamente con cattolici e ambientalisti, contro l’installazione dei missili Cruise a Comiso.
Contro la morte nucleare, La Torre aveva portato in piazza centinaia di migliaia di persone: costituiva, per gli Stati Uniti, un pericolo reale, immediato. Raccontò, per questo, d’esser pedinato da uomini dei servizi segreti. Intuì, attraverso la lettura di documenti riservati, e con l’aiuto di alcuni esperti consultati in segreto, la presenza in Sicilia di una rete segretissima legata alla Nato. E si trattava, naturalmente, di Gladio (o Stay Behind).
Cosa unisce, quindi, tanti omicidi e tante stragi: di giornalisti, politici, magistrati?
La risposta è semplice (pure se non dimostra che quel nesso sia la causa della loro morte). Il colore nero. Il nero delle alleanze oscure: con servizi segreti italiani e stranieri. Il nero dei neofascisti. Il nero dell’eversione armata.
A capire, erano stati per primi i giornalisti, sin dal ’70.
Mauro De Mauro e Giovanni Spampinato s’erano imbattuti, in modi diversi, in quel colore nero (De Mauro in Junio Valerio Borghese e nel Golpe che preparava; Spampinato nei neofascisti che allora affollavano Ragusa: Delle Chiaie, fra gli altri), così come Peppino Impastato e Mauro Rostagno: Impastato aveva messo il naso nella strage di Alcamo del ’76 (dove il nero abbonda e ricopre ogni cosa, persino la verità giudiziaria), e Rostagno s’era spinto oltre, fino ai traffici d’armi con la Somalia.
Poi, capirono i magistrati.
Pietro Scaglione, procuratore della Repubblica, indagava sulla morte di De Mauro. Venne ucciso nel ’71, e subito scattò una campagna di diffamazione che impedì per decenni di far luce sulla sua morte. Vittorio Occorsio fu ucciso a Genova da un neofascista palermitano, Pierluigi Concutelli, killer a conoscenza dei segreti dell’alleanza nero mafiosa siciliana. Gaetano Costa fu il testardo indagatore dei misfatti di Rosario Spatola, legato all’”americano” Michele Sindona. Giangiacomo Ciaccio Montalto e Carlo Palermo finirono nel mirino per aver scoperchiato, a Trapani, il calderone dei traffici d’armi e droga: Palermo si salvò ma lasciò la magistratura. Rocco Chinnici, nel suo diario segreto, scrisse dell’omicidio Mattarella, di De Mauro e della presenza di Sindona in Sicilia: dinamite. E poi, le stragi del ’92, per eliminare Falcone e Borsellino e sovvertire la storia d’Italia: storia che è ancora da scrivere. Ma in via D’Amelio le ombre, il nero, s’infittiscono.
E infine, i politici.
Michele Reina venne ucciso all’indomani di un accordo tra la sua Dc e il Pci (quasi esattamente un anno dopo il rapimento a scopo di omicidio di Aldo Moro: autore, dunque, dello stesso imperdonabile “errore” politico; e la sua morte, con un primo depistaggio, venne imputata alle Brigate Rosse). Piersanti Mattarella, il 6 gennaio del 1980, infranse, per la terza volta, quella regola vigente dal dopoguerra: mai il Pci nel governo; e la moglie di Mattarella riconobbe nell’assassino il volto di un terrorista nero, quello di Giusva Fioravanti, ma non venne creduta. Poi, La Torre. E infine, l’ex sindaco Dc Giuseppe Insalaco (che alcune inchieste ipotizzarono vicino ai servizi segreti e a Gladio).
Questa è solo una parte della storia: bisognerebbe raccontare della morte di poliziotti, carabinieri; del Generale dalla Chiesa. Tout se tient, come si dice. Ci sarebbe molto da rileggere: ad esempio, il rapporto di quel vice questore siciliano, Giuseppe Peri, su mafia, neofascismo, sequestri e attentati.
I libri sono importanti. Dicono quasi tutto. Leggete i due volumi su La Torre di Sorrentino e Mondani, per Castelvecchi, e di Vasile e Lo Monaco, per Flaccovio. Poi, provate a mettere insieme le tessere del mosaico. Ne vien fuori la Sicilia nel ventesimo secolo. E forse, l’Italia.
QUELLI DI COMISO
Avrei voluto scrivere di tutto, stavolta.
Del ragazzo di Acireale che ha denunciato per stupro un sacerdote e dei sacerdoti che ho conosciuto: umanissimi, santi o peccatori: del missionario in Kenya, smagrito dalla fede e dalla fame, del parroco ucciso a Palermo, e dell’insegnante che nel 1978, all’indomani di un omicidio, chiese alla mia classe di implorare il Paradiso: non per Aldo Moro e la sua scorta bensì per un capomafia, definito “brava persona”.
O della tesi di laurea su Angelo Russo, il primo interprete del Catarella di Montalbano, mezzo secolo dopo la “Fenomenologia di Mike Bongiorno” azzardata da Umberto Eco: del reciproco intrecciarsi del genio di Russo e di Camilleri.
Avrei voluto scrivere dei rifiuti che soffocano Palermo e della Palermo dei politicanti.
Scrivo invece di un giovane professore tedesco, di un nonviolento sardo e della scoperta del naturismo, trent’anni fa, a Comiso.
Un anno fa, era l’11 febbraio, Jochen Lorentzen stava facendo jogging, quando si è accasciato per terra ed è morto. Era a Pisa, per una conferenza. Nell’estate dell’83, Jochen era a Comiso, per l’International Meeting against Cruises. Migliaia di ragazzi in un campo pacifista: da tutta Europa e dagli Stati Uniti, contro i missili nucleari, i Cruises, schierati in un vecchio aeroporto, contro l’Urss o, secondo alcuni, contro quel matto di Gheddafi. Jochen era il mito di noi ragazzini: in prima fila, nei cortei, a proteggere i più giovani, a isolare i pochi violenti, a mediare con la polizia. Non ho più saputo nulla di lui. Fino alla notizia della morte. Docente a Copenhagen, a Cape Town, Jochen studiava le innovazioni e i modelli di apprendimento nei paesi emergenti: fedele a se stesso, come riesce a pochi.
Ad Enrico Euli, per esempio: psicologo, studioso delle relazioni interculturali, dell’ecologia e della non violenza. Al mattino presto, ci svegliava una voce non so più se inglese o tedesca: “Sono le quattro e mezza, è ora di svegliarsi”. Così, di continuo, ossessivamente. Era ancora buio. Sotto una tettoia, accosciato come un bonzo, Enrico svolgeva le sue quotidiane lezioni di resistenza non violenta. Ci sarebbero servite, diceva, in caso di cariche della polizia, dinanzi ai cancelli dell’aeroporto.
Quando le cariche arrivarono, Oscar Luigi Scalfaro era stato appena nominato Ministro dell’Interno del governo Craxi: noi provammo per un poco a resistere ai manganelli e al resto, poi ci alzammo e ce la demmo a gambe. Io persi le scarpe. Altri gli occhiali, o le ossa. Furono picchiati anche dei parlamentari.
Comiso era il centro della Sicilia, e in quel cuore antico, c’erano anche Modica, Ragusa e Vittoria, con le loro storie di terre e di contadini mai vessati da feudi e feudatari, con le serre e le cooperative: c’era un’isola nell’Isola: ricca e senza mafia. E proprio lì, sarebbero arrivati i missili, la morte cieca di Hiroshima e Nagasaki. Forse per questo era morto Pio La Torre.
A Comiso, nel nostro campo, in molti facevano la doccia nudi. Ragazzi e ragazze. Un giorno, vennero due dirigenti della mia organizzazione giovanile. Mai stati all’Imac, prima. Presero due sedie e sedettero dinanzi alle docce. Come in un locale porno. Provai un brivido di vergogna, per la prima volta. E capii che il naturismo era non provarne.
Trent’anni sono tanti. Ma quando ho letto di altre proteste, e di violenze tra i No Tav, ho pensato ad un comizio in piazza Fonte Diana, a Comiso, dopo l’ennesima carica. Un oratore, piuttosto famoso, diceva: “La prossima volta, gli idranti innaffieranno le piante della pace”. Lo interruppe qualcuno, tra i presenti, ancora bagnato. Un insulto secco. Quattro lettere. Grandi risate.
Accadde un miracolo, trent’anni fa in Sicilia. Vennero in tanti e parlarono tra di loro. Fecero la pace.
CONVERSAZIONE CON ANTONIO INGROIA
Milioni di articoli, inchieste, libri. Giornalismo, sociologia, letteratura. Scrivere di mafia significa aggiungere carta a carta. Di tanto in tanto, dopo aver nuotato in quest'oceano, dopo aver perso la rotta tra nomi, morti e processi, il dolore e la nausea inducono a giurare: mai più. Serve un po' di tempo per tornare a rendersi conto che i mafiosi vivono senza fatica in quegli scenari che per noi divengono archivi e aule processuali, e restano invece vita reale: nel tempo della nostra disillusione (ad un capo ne succede un altro, ad un sodale un altro, ad un tesoro un altro), i mafiosi trovano nuovi alleati, e minacciano la nostra libertà.
Capire è necessario, ci diciamo allora. E ricominciamo, per atto di responsabilità civile e intellettuale. Con l'aiuto di chi conosce i fatti.
Antonio Ingroia, procuratore aggiunto a Palermo, ha cominciato il suo lavoro nel 1987, nel pool antimafia di Falcone e Borsellino, smantellato - dopo la guida eroica di Antonino Caponnetto - per vicende troppo lunghe e dolorose da raccontare. Al tempo delle stragi, nel '92, aveva solo 33 anni. Si è occupato di numerose inchieste. Di processi, da pm, ne ha vinti e persi.
Vorrei trattare, in questa conversazione, anzitutto il tema del cambiamento della mafia da organizzazione a sistema. Formulo quest'ipotesi per tre ordini di ragioni: il ricorso di Cosa Nostra ad elementi esterni; la forte competizione criminale; la reazione istituzionale e civile. Per il resto, solo accennare, per brevità, ad alcune questioni cardine.
Alla luce della sua esperienza, e delle risultanze delle più recenti inchieste, ritiene anche lei che la mafia per sopravvivere possa rinunciare ad alcune delle sue caratteristiche essenziali e mutare da organizzazione chiusa ed impermeabile a sistema? Un sistema aperto ai non affiliati, e disponibile ad inglobare organizzazioni criminali più piccole o ad allearsi con altre organizzazioni.
Sono d'accordo con lei. La mafia siciliana è in una fase di riorganizzazione, in parte frutto di scelta autonoma, in parte necessitata dalla situazione. Da un lato, i duri colpi repressivi subìti ne hanno indebolito il controllo militare del territorio, e il progresso della coscienza civile ne ha minato l'ampio e spontaneo consenso popolare di cui prima godeva; dall'altro, il processo di finanziarizzazione delle proprie attività, dentro il fenomeno della globalizzazione, ha imposto ai suoi capi un adeguamento di organizzazione e strategie operative. Il risultato è che oggi l'organizzazione è meno chiusa, meno gerarchica, meno "verticale": niente capo dei capi, niente cupola, niente guerra allo Stato e così via. Molti colletti bianchi vengono inglobati nella struttura del "sistema criminale integrato" che fa blocco comune con le altre componenti che prima agivano da complici esterni, e con le altre mafie con le quali gestisce traffici illeciti. Nel contempo, è in corso anche un processo di deterritorializzazione: la mafia è meno forte e meno presente militarmente sul territorio siciliano, ed è molto più presente altrove, specialmente nelle regioni più ricche del Nord Italia. Il che, ovviamente, non significa che Cosa Nostra possa rinunciare a quel radicamento sul territorio che costituisce il suo DNA. Si tratta solo di un radicamento più diluito.
C'è ancora un consenso di massa a Cosa Nostra? Ed esiste ancora un vertice unitario e collegiale di Cosa Nostra?
Causa ed effetto di tutto ciò che abbiamo detto, sono un minore consenso culturale di massa a Cosa Nostra e un maggior consenso di convenienza da parte di chi trae profitto dalle proprie relazioni col sistema criminale; sistema che nel frattempo non ha più un vertice unico, strategico e gerarchico. Cosa Nostra, in particolare, in questo momento non ha un vero "capo dei capi" sul modello dei capi corleonesi, e neppure una cupola, ma organismi per la composizione dei conflitti: una sorta di "direttorio consultivo" dove incontrarsi per comporre le controversie sul territorio fra famiglie che operano su territori vicini.
Cosa Nostra era governativa in un sistema politico bloccato. È ancora così? O la mafia ė divenuta meno selettiva, ideologicamente parlando, e più pragmatica?
La mafia non è stata mai "governativa" per ragioni ideologiche, ma solo per interesse. Perché trae benefici dalla sua relazione col potere politico che governa ed amministra. Era quindi "anticomunista" e "antifascista" non per ragioni ideologiche, ma perché stava coi gruppi politici al governo e contro i partiti di opposizione. Infatti, era contro i socialisti quando i socialisti erano partito di opposizione, sostenne il P.S.I. quando il PSI divenne partito governativo di spicco. A maggior ragione, oggi, la mafia sceglie secondo convenienza. Chiunque sia dentro le stanze del potere, e che ci stia.
È ancora efficace lo strumento della collaborazione con la giustizia dei mafiosi pentiti? Un suicidio e un tentativo di suicidio, parlo di due casi recentissimi, indicano un disagio. A che cosa si deve?
Ovvio che i collaboratori di giustizia servono sempre contro un'organizzazione segreta come Cosa Nostra, ma questa è una fase difficile. Il grande isterilimento del fenomeno è dovuto principalmente a due fattori: agli effetti della legge sui collaboratori, entrata in vigore dieci anni fa e ispirata da una pregiudiziale diffidenza nei confronti dei pentiti, ma anche alla grave restrizione dei fondi stanziati per la sicurezza che si ripercuote sull'efficienza del servizio di protezione dei collaboratori. Una miscela che ha provocato una situazione di crescente disagio nel mondo dei pentiti, che si somma a quello - fisiologico - che si determina nel repentino cambio di vita del mafioso che inizia a collaborare con lo Stato, col risultato che alcuni dei pentiti hanno rinunciato a collaborare ed altri sono arrivati addirittura al suicidio.
La lotta alla mafia si conduce giudiziariamente e socialmente, e non di rado i due piani si sovrappongono: si può affermare che l'isolamento dei mafiosi possa dover comportare un affievolimento di alcune libertà civili? La segretezza della corrispondenza e dei conti bancari, ad esempio. Così come accadde ieri con la lotta al terrorismo interno e accade oggi con la lotta al terrorismo esterno.
Certo che la lotta alla mafia determina sacrifici, e occorre una società disposti a pagarli, anche in termini di rinuncia al massimo di estensione di alcuni diritti, come quello alla privacy (in materia di intercettazione e di controlli di corrispondenza e segreto bancario) o
alla libertà personale (con l'inasprimento di regime carcerario e di custodia cautelare per i fatti di mafia). E non sempre la nostra società è disposta a pagarne il prezzo.
Se dovesse tracciare un bilancio di questi ultimi anni, cosa metterebbe al passivo? Quali errori sono stati commessi e si potevano evitare?
Il primo fondamentale errore sta nell'aver delegato il compito di contrastare la mafia alla sola magistratura con le forze dell'ordine. Comodo alibi per molti, che la magistratura non ha saputo ben respingere: in qualche caso, anzi, facendosene carico. Altro errore, l'aver puntato tutto sulla repressione della mafia militare senza valorizzare adeguatamente il contrasto alla mafia finanziaria ed alla mafia politica. E ancora: il liquidare, per anni, il problema mafia come legato alla questione meridionale, senza considerare adeguatamente i rischi per il Nord Italia. E infine, non aver, complessivamente, il nostro Paese, compreso quanto la lotta alla mafia convenga molto più di quella convivenza, con la mafia, che è ancora l'atteggiamento prevalente.
E il principale risultato positivo?
L'avere intaccato il mito dell'impunità della mafia e dei suoi complici, ed il suo controllo totalizzante sul territorio, sottraendo alla mafia quell'ampio e spontaneo consenso di massa di cui prima godeva nelle regioni del meridione d'Italia.
Se dovesse abbandonare la magistratura per la politica, come proporrebbe di riformare la normativa antimafia e il funzionamento del sistema della giustizia? Con riferimento al contraddittorio tra le parti durante le indagini e nel processo, intendo.
Abbandonare la magistratura per la politica? Al momento non ci penso nemmeno! Però, se dovessi dare dei suggerimenti, anche da magistrato, direi: 1) accorciare i tempi del processo: consentendo maggiori ingressi nel processo a prove scritte, ed evitando le lungaggini del ripetere verbalmente ciò che è già scritto, ad esempio, nelle informative di polizia; 2) abolire il secondo grado di giudizio, l'appello, e per tutte le sentenze di primo grado, siano esse di assoluzione o di condanna.
Ieri la mafia poteva far cadere un governo o influenzare con un attentato l'elezione di un Presidente della Repubblica, e non faccio degli esempi a caso. Oggi potrebbe influenzare le borse internazionali. Ieri varammo dei reati a sanzionare la contiguità politica. E la contiguità finanziaria? Servono strumenti nuovi?
Cosa fare contro la mafia finanziaria? Innanzitutto, punire, al pari di tutti Paesi a democrazia avanzata, l'autoriciclaggio: oggi è impossibile condannare un mafioso che ricicla da sé il proprio denaro illecito. E poi, recepire in Italia la direttiva comunitaria che impone ad ogni Paese dell'UE di eseguire sul proprio territorio provvedimenti di confisca definitiva emessi in altro Paese: a causa del mancato recepimento in Italia di questa direttiva, altri Paesi membri, in base al principio di reciprocità, hanno negato la possibilità di eseguire confische definitive nei confronti della criminalità organizzata italiana. Più in generale, occorre introdurre un testo unico antiriciclaggio che contenga un aggiornamento ed un adeguamento di tutta la normativa in materia.
Un'ultima questione. Secondo le ultime risultanze investigative, alcun processi - per le stragi del '92 - sarebbero da riscrivere, e nel fallito attentato dell'Addaura dell'89 contro Falcone e due giudici svizzeri, vi sarebbero gravi responsabilità istituzionali. Ci sono state delle deviazioni, si dice. Come è stato possibile arrivare a questo punto? A sentenze definitive rivelatesi fallaci, intendo, e a nessuna verità sull'Addaura.
A proposito di stragi e Addaura (e non solo...): quel che sembra di percepire è che troppo spesso la verità è difficile da conquistare e che per farlo occorre un Paese intero che la voglia, e che si batta per averla a tutti i costi, quella verità. A volte, la mia sensazione è che prevalga la voglia di non averla, quella verità.
PUBBLICHE SCUSE
Chiedo scusa per la lunga assenza. Cercherò di farmi perdonare. Pubblico i testi finora non inseriti.
Iscriviti a:
Post (Atom)