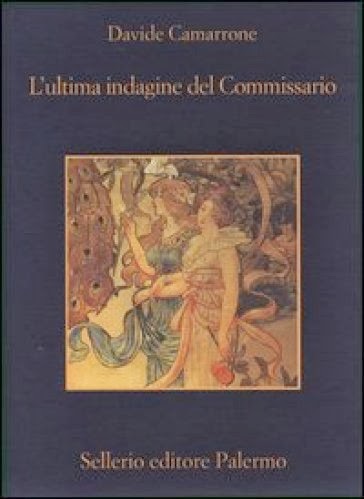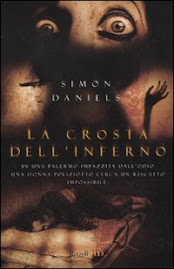I giornali, ancora di recente, hanno detto che allo Steri, a Palermo, nascerà un “Museo dell’Inquisizione”. Io non sono d’accordo. Penso alla cacciata degli ebrei da Palermo, cinque secoli fa (così come in tutto il Regno di Spagna), e allo sterminio di quelli che vollero restare. Lo Steri conserva le poche tracce che restano di quella Catastrofe. Ed è una sorta di Nemesi: doveva cancellare, ed ora conserva. Credo che Palermo abbia un debito verso quei palermitani ebrei cacciati o torturati e costretti a rinnegare la loro fede o uccisi, e uccisi comunque, e che possa saldarlo, quel debito, facendo dello Steri una sorta di Yad Vashem. Un Museo delle vittime dell’Inquisizione. Delle vittime, e non dei carnefici. La mia proposta ha la forma di un racconto.
E’ rimasto nascosto per anni tra le preziosissime macerie accumulate dai dontotò che nel dopoguerra avevano preso possesso militare dei cortili dell’Osterio dei Chiaramonte. E’ riuscito a sfuggire miracolosamente alla vigilanza dei suoi ospiti, armati di roncole e doppiette, e a districarsi indenne tra le insidie puntute dei cerchi di rame strappati alle condutture elettriche del vecchio tribunale, le precarie torri di ruote dei vecchi camion militari, i labirinti sorti fra i cumuli di mattoni sbreccati e le tavole umidicce di panche e mobili e sedie di tortura.
A fargli compagnia, in quel girone, le carogne di un cavallo e di un cane marcescenti in un buttatoio e due metope di marmo bianchissimo inneggianti all’uomo nuovo, a braccio teso.
L’uomo che sta seduto innanzi a me sembra non avere un’età ben definita, e alla mia prima domanda - chi sei, tu? - oppone un silenzio di pietra, freddo come i suoi occhi di opale, scavati su di un viso denso di rughe desertiche, modellate dal vento.
Mi ha detto, incontrandomi, e tendendomi la sua mano freddissima, che ha il cuore gonfio di tristezza. In quei cortili e tra i palazzi che li delimitano, si trova un cimitero dimenticato, e lui, l’ultimo testimone della Catastrofe di Palermo, vuol raccontarmene la storia.
La sua storia.
Viveva nei pressi dell’antica Sinagoga, la più ricca del Ghetto, per via del contenuto del suo pozzo: la sua famiglia, che a Palermo, assai prima del Mille, era giunta al seguito di alcuni cavalieri arabi, aveva contribuito al tesoro della comunità, e lui stesso, da sarto, aveva donato, al Rabbi, le sue vesti; da mobiliere, aveva restaurato gli arredi; e da fabbro e da vetraio, aveva rimesso al loro posto le finestre distrutte dai primi accenni d’odio, dei cristiani.
Uomo di molteplici talenti, aveva custodito i rotoli di una sapienza oscura, che contemplava il prolungamento della vita, e la creazione di uomini dal fango, e di luci dal buio.
Mi state dicendo che non siete morto, gli chiedo? E lui, mi mostra il palmo delle sue mani, perfettamente lisce, come quelle di un bambino. Anche i miei piedi sono giovani, dice. Il resto, è secco, e aspetta di mutare in polvere.
Aveva, Isacco, questo è il suo nome, una moglie e sei figli, ed un giorno, aveva appena ordinato una gran festa per il bar mitzvah del suo maggiore, seppe da un cugino del Rabbi che in Sinagoga s’era discusso a lungo, tra gli anziani, dell’editto spagnolo, e che c’era da prepararsi ad una nuova fuga dall’Egitto, e che il Faraone, nelle fattezze della Regina di Castiglia, non voleva intender ragioni: gli ebrei dovevano lasciare subito il Regno, da un mare all’altro.
La voce aveva fatto rapidamente il giro di tutte le case, come l’acqua che scorre nei canali pulitissimi di un viridario e bagna uniformemente i frutti della terra, senza chiedersi di che forma siano e quale sia il loro sapore: tutti, poveri e ricchi, morigerati e peccatori, seppero allo stesso modo del loro destino. Vi fu chi si lasciò prendere dalla disperazione, e mise alla porta uno straccio di porpora, e chi, invece, si disse che erano da considerarsi tutte fandonie, e che a Palermo, gli ebrei erano da sempre ben visti, come i greci, e che se qualcosa di vero era da prendersi, in quel timore giunto sulle navi della Regina, tra i mozzi e i messaggeri, presto sarebbe sbiadito, al sole della Sicilia.
Ebbero ragione gli uni e gli altri. Sebbene molti anni dovessero ancora trascorrere, il nodo di forca infine si strinse al collo della comunità. E chi attese, guadagnò dall’incoscienza, e perse dalla ragione.
Tra la disperazione della cacciata imminente e l’euforia di un possibile ravvedimento, vi fu infatti chi mise all’incanto i propri averi, con discrezione, e ne ricavò una parte poco più che miserabile del loro valore. Per tutti gli altri, s’aprirono invece le porte dell’Inferno: vi fu chi perse le commesse, chi il diritto al pagamento, chi la licenza di svolgere le arti ed i mestieri. Chiusero le Yeshiva, e i pozzi furono scoperchiati, e depredati; le Sinagoghe ridotte a cave di pietra, e a porcilaie.
Furono rimosse le insegne, e demolite le abitazioni. L’anello del Ghetto si fece più stretto, e ancora più stretto. E più stretto.
La famiglia di Isacco subì l’onta dello smembramento, e la moglie, e i figli, furono caricati su due velieri, diretti la prima ad Oriente e i secondi in Africa, a trovar fortuna. Un giorno, dissero. Un giorno, si dissero, un giorno ci rivedremo.
Isacco provò a disfarsi del suo patrimonio. Ne ricavò insulti, e sputi. Tutto si fuse insieme, in un solo crogiuolo incandescente: l’odio, il disprezzo, la rivalsa. Negli occhi dei Gojim, dei Gentili, Isacco vide una luce che non aveva mai brillato così tanto, prima d’allora: la cupidigia. L’amore s’era interrato come l’acqua dei vecchi fiumi della città, e il mare, negli anni che seguirono, si ritirò fino a lasciarne secco il cuore. Arido come il deserto.
Isacco, senza più un chicco del metallo che per secoli la sua famiglia aveva custodito, cucito nelle vesti per il momento della fuga, che un giorno, di certo, dicevano gli anziani, sarebbe giunto, divenne un accattone, si confuse tra i rifiuti della città incancrenita. Per anni, tese la mano per raggranellare ciò che avrebbe potuto persuadere un marinaio a caricarlo in una stiva di una nave diretta ad Oriente o in Africa, dalla moglie, o dai figli. E ogni volta, il denaro, raccolto e custodito nelle sue vesti, si smarrì, fu rubato, o ceduto per un tozzo di pane.
Isacco fu riconosciuto da un buon amico, un Gojim, che lo persuase alla conversione, ed era una conversione al solo Dio del Cielo, per Isacco. Nel giro di qualche giorno, ripulito, e confortato di un giaciglio, e di vesti colorate, fu arrestato, tacciato di marranesimo e tradotto in una cella del primo carcere dell’Inquisizione.
Il racconto di Isacco si fa confuso, alle mie povere orecchie.
Non mi decidevo a morire, dice. Gli eretici, coloro che pensavano con la testa loro, venivano inceneriti. I famigli venivano scarcerati. I nobili trovavano un accordo.
I guardiani passavano. I giudici invecchiavano.
Il vecchio carcere fu chiuso e demolito.
Fu deciso che in catene giungessi, dice Isacco, insieme ai pochi conversos rimasti e ad alcune donne tacciate di stregoneria, e che solo avevano i torti di saper leggere, o far di conto, o di padroneggiare il latino ed il greco, al carcere nuovo dell’Osterio, e da qui, spiega, da quest’Inquisizione che dissero Santa non mi son più mosso. Fino ad oggi.
Scrissi le preghiere accettate nella loro lingua, ché mi salvassero la vita terrena, e nascosi le mie nelle loro empie figurazioni, ché mi salvassero la vita eterna. E per scrivere, e disegnare, usai tutte le mie miserie corporali, e le uova marce e il latte acido che le donne pagavano con le loro vergogne.
Ho visto morire tutti quanti, e il puzzo delle loro carni bruciate è giunto alle mie nari rivelandosi appieno, quasi che le polveri sospese pronunciassero gli addii, e dicessero, con i nomi, le ultime volontà dei condannati.
Il mio Atto di Fede venne dimenticato. Ripetendo i versetti della Sapienza, vidi invecchiare la corteccia del mio corpo, e fluire inspiegabilmente all’interno una linfa fresca come latte di capra.
Mi feci però incorporeo, e potevo manifestarmi ad alcuni, o solo alcuni potevano vedermi.
Durante un interrogatorio, mi scorsero due paia d’occhi, e il terrore se ne impadronì. Il Sommo Inquisitore venne ucciso, la sua testa percossa da un Frate, con violenza, contro la pietra: il sangue e le cervella dello spagnolo inumidirono il tufo e s’insinuarono nelle camere d’aria sino alle segrete, e lì giacciono ancora, tra le ossa delle streghe e dei conversos.
Il luogo che era stato dell’Inquisizione e dell’Ingiustizia divenne un Tribunale del Regno nuovo, e giunsero i carri senza cavalli, e assistetti a processi che mi ricordavano i miei, quasi che il tempo non fosse passato.
Ricordo un uomo anziano, che per un caso, giunse a scrutare tra le demolizioni, e aperse la bocca in uno sbadiglio di stupore, dinanzi ai miei graffiti. Ed altri ancora, molto più tardi. Un uomo che teneva il fuoco sulle labbra ed un altro che lampeggiava con uno strano attrezzo. Tutto fu poi chiuso, e furono padroni i dontotò.
Ora, delle donne, delle streghe che chiamano restauratrici, riportano le mie preghiere e i miei disegni al colore delle mie miserie corporali, e delle uova marce e del latte acido. E tanti, li osservano, come se ne capissero il significato.
Ora che la mia Palermo non conserva più alcun segno dei Giudei, è questo il solo luogo che ne custodisce la memoria. La memoria della loro Morte. La memoria della Catastrofe di Palermo.
Gli dico che altre Catastrofi ci sono state, e ben più sanguinose. Gli dico dei camini di Birkenau. Dell’assedio di Varsavia. Dei pogrom russi. Di Israele. Dell’undici settembre.
Gli dico della dimenticanza di Palermo per i suoi ebrei, che furono decine di migliaia. E della segreta architettura di Damiani Almeyda, di quell’Archivio ricostruito ai margini della Giudecca come una Sinagoga.
La mia Sinagoga?
Sì, Isacco, la vostra.
Gli dico che di quelle celle, che lui abitò e nelle quali non morì, e di quei graffiti, che segnarono il suo passaggio dal corporeo all’incorporeo, faranno un Museo, e gli dico cos’è un Museo. Sarà un Museo dell’Inquisizione, che tutti potranno visitare.
Degli uomini e delle donne.
Dei Gojim, dice.
Sì. Gentili. Ed ebrei.
Vorrei che fosse un Museo degli ebrei morti, dice. Un Museo dei Morti. Un Museo delle vittime dell’Inquisizione. Non dei carnefici.
Isacco va via. E per un attimo, nei suoi occhi, di vetro, si riflette il mio sguardo.
In quest'antica fotografia, il prospetto dell'antico palazzo Chiaramonte Steri: fino agli anni Sessanta, fino al massacro deciso dall'Università in forma di restauro (ne scrisse Sciascia, fra l'altro).